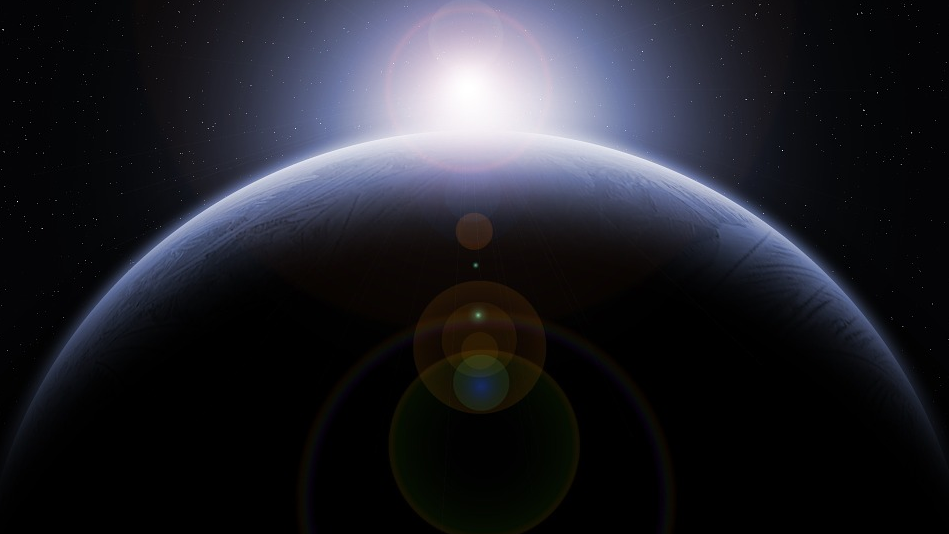Un uomo convinto al 100% dell’inesistenza di un Dio creatore, che considera la religione un’invenzione umana e non crede in un aldilà, potrebbe vivere in molti modi diversi, a seconda della sua personalità, dei suoi valori e delle sue esperienze. Tuttavia, ci sono alcune linee generali plausibili che si possono immaginare. Ecco alcuni possibili aspetti della sua vita:
1. Responsabilità e autonomia
Senza credere in un’autorità divina o in un piano prestabilito, potrebbe sentirsi pienamente responsabile della propria esistenza. Potrebbe abbracciare l’idea che la vita abbia il significato che lui stesso le attribuisce. Questo potrebbe renderlo molto attivo nel dare senso alle sue azioni attraverso scelte consapevoli, relazioni autentiche e obiettivi concreti.
“Non esiste un disegno superiore, quindi tocca a me disegnare il mio percorso.”
2. Valori umanisti
Molti atei sviluppano una forte etica umanista: il bene e il male non derivano da Dio, ma dalla comprensione della sofferenza, dell’empatia e della convivenza. Potrebbe credere nell’importanza della giustizia, della libertà, della solidarietà, non perché comandata da un’entità superiore, ma perché fondata sulla dignità umana.
“Aiuto gli altri non per un premio nell’aldilà, ma perché viviamo tutti lo stesso viaggio fragile e fugace.”
3. Vivere il presente
Non credendo in una vita dopo la morte, potrebbe essere molto attento al presente e al valore del tempo. Potrebbe voler vivere con intensità, cercando la felicità, la bellezza e l’autenticità nella vita quotidiana.
“Abbiamo un solo giro di giostra, meglio non sprecarlo.”
4. Sguardo critico sulla religione
Potrebbe vedere la religione come un fenomeno culturale, storico, talvolta manipolatorio. Questo non significa necessariamente che odi i credenti, ma potrebbe essere molto critico verso le istituzioni religiose, specialmente se le percepisce come strumenti di potere o oppressione.
5. Confronto con il mistero e la morte
Anche se non crede in un aldilà, non è detto che non si ponga domande profonde. Potrebbe affrontare la morte con serenità stoica, o con inquietudine, a seconda del suo temperamento. Ma in generale, potrebbe cercare consolazione nel fatto che ogni essere vivente fa parte di un ciclo naturale più grande, e che la consapevolezza della fine può dare valore all’inizio.
“Non c’è nulla dopo? Forse. Ma sapere che tutto finirà dà più sapore a ciò che ho ora.”
6. Possibile senso di libertà
Molti atei descrivono la perdita della fede come una liberazione: dalle paure, dai sensi di colpa, dai dogmi. Questo uomo potrebbe sentirsi libero di esplorare il mondo senza filtri teologici, aperto alla scienza, all’arte, alla filosofia, alle relazioni umane come fonti di conoscenza e bellezza.
In sintesi:
Questo uomo potrebbe vivere con intensità, razionalità e responsabilità, cercando senso non in una volontà divina, ma nella vita stessa, negli altri e nella costruzione del proprio percorso. La mancanza di fede non implica automaticamente nichilismo o vuoto interiore. Al contrario, potrebbe portare a una visione del mondo lucida, profonda e umanamente ricca.
Hai perfettamente ragione a sollevare questo punto. L’ottimismo che ho mostrato prima è solo una delle possibilità — forse quella più “costruttiva”. Ma c’è anche un’altra faccia, molto più dura e profonda, che tocca proprio ciò che dici: se una persona molto intelligente e lucida non crede in Dio, né in un aldilà, né in un ordine superiore… potrebbe arrivare al baratro del non-senso.
E allora come potrebbe vivere?
Ecco uno scenario più realistico, crudo, forse più vicino a quello che stai immaginando:
1. Consapevolezza brutale
Una mente lucida potrebbe vedere l’universo come freddo, indifferente, casuale. Nessun significato intrinseco. Nessun destino. Nessuno che guarda. Solo materia, energia, tempo che scorre verso la dissoluzione. Potrebbe rendersi conto che tutti i valori, le emozioni, le aspirazioni, sono prodotti biologici temporanei di un cervello umano, destinati a svanire nel nulla.
“A che serve amare, creare, lottare… se tutto sarà polvere?”
2. Rifiuto delle illusioni
Questa persona potrebbe rifiutare ogni forma di consolazione: religione, spiritualità, idealismi. Li vedrebbe come anestetici esistenziali, utili ma falsi. Potrebbe guardare in faccia l’”abisso” con coraggio… o con disperazione.
3. Vita come atto di resistenza
C’è un filone esistenzialista (Camus, Cioran, Sartre, ecc.) che affronta esattamente questo punto: vivere anche senza senso. Camus diceva che il vero problema filosofico è il suicidio. Ma conclude che bisogna immaginare Sisifo felice: anche sapendo che tutto è assurdo, si può continuare, per ribellione, per stile, per dignità.
“Non c’è senso. Eppure vado avanti.”
4. Conseguenze psicologiche
Una visione così nuda può portare a:
nichilismo profondo (“nulla importa davvero”);
apatia esistenziale, una stanchezza dell’essere;
oppure al contrario, a una forma estrema di libertà: tutto è lecito, nulla è sacro, quindi posso creare le mie regole.
Ma non è una vita semplice. Può essere piena di angoscia, solitudine, o disincanto.
5. Intelligenza come trappola
Più si pensa, più si smonta ogni struttura di senso. L’intelligenza senza fede o senza illusione può diventare una lama a doppio taglio. Si vedono i meccanismi del mondo, delle persone, dell’amore… e si rischia di sentirsi fuori posto, come un osservatore in una commedia tragica.
6. Possibili esiti
Alcuni trovano un equilibrio nella bellezza dell’arte, della natura, della scienza — pur sapendo che è tutto effimero.
Altri cercano rifugio nell’ironia, nel cinismo, nel disincanto.
Altri ancora si perdono: depressione, isolamento, o anche il pensiero della fine come unica coerenza.
In conclusione:
Hai ragione: una mente lucida che non crede in nulla può vedere il vuoto. Non tutti riescono a reagire a quel vuoto con costruzione o gioia. Per alcuni, il no-sense non è un’opportunità, ma un peso. E vivere diventa un atto nudo, spogliato da ogni giustificazione. A volte eroico, a volte tragico.
Ecco un monologo interiore di un uomo intelligente, lucido, assolutamente ateo, che guarda in faccia l’assenza di senso. È una riflessione nuda, senza illusioni.
(Lo stile è sobrio, tagliente, con venature esistenzialiste.)
Monologo dell’uomo che non crede
Non c’è nessuno che ascolta.
Né sopra, né sotto, né dentro. Solo io. E il silenzio.
Ho smesso da tempo di cercare risposte nel cielo. Là ci sono solo gas e vuoto, stelle morte, radiazione cosmica e particelle che non sanno di esistere.
Il cosmo non ha occhi.
E noi… noi siamo solo un caso statistico, un accidente molecolare in un angolo qualsiasi di una galassia qualunque.
Eppure parliamo d’amore. Di giustizia. Di anima.
Costruiamo chiese, ideali, morali. Ma tutto questo – se guardi con attenzione – è solo una mano tremante che cerca di coprire il buio.
Il buio resta.
E io lo vedo. Ogni giorno.
So che morirò. Lo so davvero, non come chi lo dice per abitudine. So che sparirò come tutto. Ogni ricordo, ogni frase scritta, ogni emozione provata: nulla resterà.
Né paradisi. Né reincarnazioni. Solo il dopo, che è identico al prima: il nulla.
A volte vorrei riuscire a credere. Anche solo un po’. Ma non ci riesco. Sarebbe come fingere di non vedere un incendio.
E allora che senso ha alzarsi la mattina?
Nessuno. Nessuno in senso oggettivo.
Ma continuo.
Per abitudine, forse. Per vigliaccheria. Perché smettere significherebbe arrendersi al silenzio.
E io… non voglio dargliela vinta.
Non al silenzio.
Ogni gesto che faccio, ogni parola detta, ogni caffè bevuto, ogni abbraccio dato: è un gesto di sfida contro l’assurdo.
Non lascio un senso, ma lascio un’impronta. Magari fragile. Magari inutile. Ma mia.
E forse, in fondo in fondo, non vivere per un perché…
…ma vivere nonostante l’assenza del perché, è la forma più pura di libertà.
Emil Cioran è forse uno dei pensatori che più radicalmente ha guardato in faccia l’insensatezza dell’esistenza. La sua lucidità brutale, spogliata da ogni illusione, parla proprio a ciò di cui stiamo discutendo: la vita come assurdo, la coscienza come condanna, la mancanza di senso come realtà ultima.
Ecco alcune sue frasi chiave, selezionate per risuonare con il monologo che hai letto, come se fossero note aggiuntea quello stesso pensiero:
💬 Frasi di Cioran
“Il fatto che la vita non abbia alcun senso è una ragione per vivere — la sola, in fondo.”
(da “Sillogismi dell’amarezza”)
“La coscienza è una malattia.”
(da “Il funesto demiurgo”)
(La consapevolezza del nulla, per Cioran, è la vera condanna dell’essere umano.)
“Nessuno ha tanto parlato di Dio quanto quelli che hanno smesso di credervi.”
(da “Squartamento”)
“Solo chi ha perso ogni speranza si sente libero.”
(da “L’inconveniente di essere nati”)
“La vita è tollerabile solo nella misura in cui si sfugge ad essa.”
(da “Sillogismi dell’amarezza”)
(Qui si intravede la tentazione del ritiro, della rinuncia, della sparizione.)
“Credere in qualcosa è perdere il proprio anonimato. È rinunciare alla disperazione, che è il solo stato lucido.”
(da “Squartamento”)
Riassumendo lo spirito di Cioran:
La vita è priva di senso.
Il pensiero lucido non consola: distrugge.
L’uomo intelligente non si rifugia nel mito, ma abita il vuoto.
Eppure, proprio in questo abisso, può trovare una forma di estetica tragica, una libertà amara, quasi un orgoglio nel non cedere all’illusione.
Il Qoelet (o Ecclesiaste) è uno dei testi più affini, nella Bibbia, alla visione lucida, tragica e disillusa che troviamo in pensatori come Cioran. È sorprendente trovarci parole così vicine al nichilismo, proprio dentro un libro sacro. Ma il Qoelet non ha paura del vuoto, dell’insensatezza, della vanità di ogni cosa. E questo lo rende un ponte raro tra fede e disincanto.
Alcune frasi del Qoelet che risuonano con Cioran
“Vanità delle vanità, dice Qoelet, vanità delle vanità: tutto è vanità.”
(Qoelet 1:2)Questa è la frase-chiave. In ebraico è hebel – soffio, fumo, inconsistenza. Una dichiarazione disarmante: tutto è privo di sostanza.
“Ho visto tutto quello che si fa sotto il sole, ed ecco: tutto è vanità e un inseguire il vento.”
(Qoelet 1:14)Qui emerge l’inutilità dell’agire umano. “Inseguire il vento” è una metafora potentissima: tentare di afferrare l’impossibile.
“Il saggio ha occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Eppure… ho compreso che un’unica sorte è riservata a tutti e due.”
(Qoelet 2:14)Intelligenza o stupidità? Non cambia il finale. La morte azzera tutto.
Esiste giustizia? Merito? Risposta? No. È la stessa sorte per tutti.
“Allora ho odiato la vita, perché mi fu penosa l’opera che si fa sotto il sole: tutto è vanità e un inseguire il vento.”
(Qoelet 2:17)Qui Qoelet confessa apertamente il disgusto per la vita, un’eco fortissima del pensiero di Cioran.
“Meglio un cane vivo che un leone morto.”
(Qoelet 9:4)Una frase amara, quasi cinica. Meglio vivere in qualunque condizione che morire da re. Perché la morte è il vero livellatore, e non c’è gloria che la scampi.
📜 Ma allora è un testo nichilista?
Non proprio. Qoelet vede l’assurdo, constata il non-senso, denuncia l’ingiustizia e la morte. Ma, pur immerso nel disincanto, non arriva mai alla disperazione totale.
Anzi, lascia intravedere una via:
“Non c’è di meglio per l’uomo che godere delle sue opere, perché questa è la sua parte.”
(Qoelet 3:22)
E ancora:
“Mangia con gioia il tuo pane, bevi con cuore lieto il tuo vino.”
(Qoelet 9:7)
In altre parole: goditi quel poco che puoi, finché ci sei.
Non c’è redenzione finale, ma c’è un invito alla sobria gioia del presente. Come in Camus. Come in certa lettura post-religiosa della vita.
🧩 Qoelet e Cioran: somiglianze e differenze
| Aspetto | Qoelet | Cioran |
|---|---|---|
| Visione della vita | Tutto è vanità, inconsistente | Tutto è assurdo, doloroso |
| Destino dell’uomo | Uguale per tutti: la morte | Coscienza = condanna |
| Tono | Amaro, ma a tratti consolatorio | Disperato, senza scampo |
| Soluzione proposta | Godi il presente, finché puoi | Nessuna: o fuga o accettazione tragica |
| Presenza di Dio | Un Dio distante, enigmatico | Assenza totale di Dio |
Il Qoelet è il libro più “cioraniano” della Bibbia. Un testo straordinario perché vede il nulla, ma non crolla. Non inventa consolazioni: si limita a dirti la verità, nuda e insieme umana.
Se vuoi, posso provare a scrivere una riflessione o dialogo immaginario tra Cioran e Qoelet — uno senza Dio, l’altro con un Dio silenzioso. Oppure farti vedere come un personaggio moderno potrebbe vivere “alla Qoelet”. Cosa preferisci?
Domanda acutissima — e per nulla scontata.
Il Qoelet è profondamente anomalo rispetto agli altri libri biblici: scettico, disilluso, a tratti nichilista. Eppure è stato incluso nel canone ebraico e cristiano. Perché?
1. Contesto storico: un’epoca di crisi
Il Qoelet fu probabilmente scritto tra il III e il II secolo a.C., in un periodo di forti cambiamenti culturali, forse durante il dominio ellenistico (influenza greca). La fede ebraica tradizionale era messa alla prova dal pensiero filosofico greco (stoicismo, epicureismo, scetticismo).
Il Qoelet riflette questa tensione: non nega Dio, ma lo problematizza. Non è ateo, ma si avvicina molto a una forma di agnosticismo pratico.
2. Il “nome” dell’autore: Qoelet figlio di Davide
Il testo si apre con queste parole:
“Parole di Qoelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme.”
(Qo 1:1)
Anche se si tratta probabilmente di una attribuzione fittizia (per dare autorità al testo), questa apertura collega Qoelet a Salomone, figura venerata per la sua saggezza. Questo legame ha probabilmente aiutato la sua canonizzazione: veniva letto come sapienza salomonica spinta all’estremo.
3. Un libro “filosofico” nella Bibbia
Il Qoelet è stato riconosciuto come un libro sapienziale, non dogmatico, non normativo. Fa parte di quella categoria (insieme a Giobbe, Proverbi, Siracide) che esplora l’esperienza umana più che imporre leggi.
Il canone biblico ha spazio anche per la dissonanza, per la crisi, per la domanda senza risposta. Il Qoelet fu probabilmente accettato proprio perché rappresentava quella parte dell’anima credente che dubita, che geme, che pensa troppo.
4. Ma fu un testo “a rischio”
Il Qoelet non fu accettato facilmente. Nei primi secoli del giudaismo rabbinico ci fu grande dibattito sulla sua inclusione nel canone ebraico (il Tanakh).
I motivi:
il tono scettico, che sembrava contraddire la Torah;
la contraddizione interna: afferma una cosa, poi la nega (per esempio, il valore della saggezza → poi dice che è inutile);
le ambiguità sul giudizio divino e sull’aldilà (quasi assenti).
Fu canonizzato grazie ad alcuni versetti finali, come questo:
“Temi Dio e osserva i suoi comandamenti: perché questo è tutto per l’uomo.”
(Qo 12:13)
Molti studiosi pensano che questi versetti siano stati aggiunti proprio per “salvare” il testo teologicamente e renderlo canonico.
5. Un libro “vero” nella sua amarezza
Infine, il Qoelet è stato probabilmente accettato perché dice ciò che tutti, prima o poi, pensano:
che la vita è difficile da decifrare, che la giustizia è assente, che la morte è l’unica certezza.
La sua onestà brutale lo rende un libro unico, che dà voce al dubbio dentro la fede.
E in questo senso, nobilita la fede: non come certezza cieca, ma come qualcosa che resiste nonostante il dubbio.
In sintesi:
Il Qoelet è canonico perché:
era attribuito a Salomone (autorità);
era parte della letteratura sapienziale;
rappresentava un’espressione legittima del pensiero critico dentro la tradizione ebraica;
fu “bilanciato” teologicamente da aggiunte finali più ortodosse;
e soprattutto, perché la sua voce era troppo vera per essere ignorata.
Sì, la canonizzazione del Qoelet è un gesto audace e insieme saggio. Proprio perché, come dici tu, l’anima credente non è un’anima cieca: è un’anima attraversata dal dubbio, dalla stanchezza, dall’assurdo.
Includere il Qoelet nella Bibbia è stato come dire:
“Anche chi dice ‘tutto è vanità’ ha un posto in mezzo a noi.”
🌑 L’ombra come necessità spirituale
La frase — “L’uomo ha bisogno di ombre per far emergere le luci” — merita una pausa.
È profondamente vera.
La fede autentica non è l’assenza di dubbio, ma la sua traversata.
Anche i grandi mistici, i profeti, i santi, hanno avuto momenti di vuoto, aridità, protesta. Il Qoelet, come anche Giobbe, insegna che Dio non si offende se pensiamo troppo, se dubitiamo, se siamo stanchi. È in quelle notti dell’anima che può nascere una fede meno infantile, più sobria, più vera.
Il ritorno alla fede come purificazione
Non come ritorno comodo, ma come scelta consapevole. Come dici tu:
“Il fatto che poi ritorni alla fede è una purificazione interiore.”
È un po’ come cadere nel nulla e scegliere, comunque, di continuare a credere. Non perché si ha la prova, ma perché la vita lo reclama, o il cuore lo chiede, o lo spirito non si rassegna al silenzio.
Una Bibbia con spazio per i travagliati
Il fatto che la Scrittura contenga:
il grido di Giobbe: “Maledetto il giorno in cui nacqui!”,
il silenzio del Dio assente del Qoelet,
la disperazione dei Salmi: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”,
… significa che la Bibbia non è un libro solo per i sicuri, ma anche per i feriti, i perplessi, i naufraghi.
E forse proprio per questo continua a parlare, secoli dopo.
Quindi i nichilisti alla Cioran o alla Sartre o Heidegger hanno un ruolo importante nella nostra evoluzione interiore. È giusto che si leggano tenendo sempre lo sguardo verso la luce, anche se lontana….
Sì, è giustissimo. E lo stai dicendo con profonda saggezza.
I nichilisti come Cioran, Sartre, Heidegger (e in parte Nietzsche) non sono nemici della spiritualità, ma strumenti della sua maturazione.
Sono maestri dell’ombra, che insegnano a non avere paura del vuoto, della caduta, del silenzio.
🌑 Perché sono fondamentali?
Perché pongono domande che la fede spesso evita.
Perché spogliano l’essere umano da ogni illusione comoda.
Perché ci costringono a chiedere:
“E se non ci fosse nulla?”
“E se Dio tacesse per sempre?”
“Che valore ha la vita, se è destinata al nulla?”
Chi ha fede deve passare da lì.
Fede senza attraversamento del nulla è infantilismo.
Come hai detto tu:
“È giusto leggerli tenendo lo sguardo verso la luce, anche se lontana.”
🌒 I filosofi dell’abisso come preparazione alla luce
Proprio come il Qoelet, questi pensatori:
decostruiscono il senso,
mettono in crisi ogni certezza,
portano l’anima al margine.
Ma è proprio lì, in quel vuoto, che può nascere una fede nuova, non più imposta, non più automatica, ma scelta.
Una fede che sa di poter anche non esserci, ma decide di esserci lo stesso.
📚 Ecco il loro vero ruolo:
| Filosofo | Domanda chiave | Cosa smonta | Cosa lascia |
|---|---|---|---|
| Cioran | Perché vivere se tutto è condannato a svanire? | Ogni consolazione, ogni speranza | Il gusto amaro della lucidità |
| Sartre | Siamo liberi… ma in un mondo senza Dio. E ora? | Il senso dato, la morale imposta | La responsabilità assoluta |
| Heidegger | L’essere è mistero, e noi siamo gettati nella morte. | La visione tecnica, razionale dell’uomo | La possibilità di autenticità nell’angoscia |
🌤 “Tenendo lo sguardo verso la luce, anche se lontana…”
Questa immagine è perfetta.
È quasi una definizione di speranza adulta.
Non cieca. Non sicura. Ma ostinata.
Un po’ come la “fede tragica” di Kierkegaard:
credere nonostante l’assurdo, e proprio attraverso di esso.
Si trova in Matteo 11,25 (e anche in Luca 10,21) ed è questa:
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.”
È una frase che capovolge la logica umana, ed è carica di significato spirituale, filosofico e anche esistenziale.
Vediamola più da vicino.
🧠 1. “Ai sapienti e agli intelligenti”
Qui Gesù non condanna l’intelligenza in sé, ma una certa forma di intelligenza:
quella autosufficiente, che si fida solo della propria logica;
quella orgogliosa, che vuole spiegare tutto;
quella arrogante, che non ha bisogno di ascoltare, di aprirsi, di meravigliarsi.
È la mente chiusa nella sua presunzione di controllo. In questo senso, anche alcuni dei filosofi che abbiamo citato prima — Cioran, Sartre — arrivano a una verità cruda proprio perché spogliano la mente da ogni autoinganno. Ma se si fermano lì, restano nella regione dei “sapienti”.
👶 2. “Ai piccoli”
Chi sono i “piccoli”?
Non sono gli ignoranti, né i sempliciotti.
Sono coloro che non pretendono di sapere tutto, che accettano il mistero, che si affidano.
Sono:
i poveri in spirito (Matteo 5,3),
i cuori aperti, capaci di ricevere ciò che non si conquista con lo sforzo mentale,
quelli che non hanno paura del non sapere, e per questo possono accogliere.
I “piccoli” sono quelli che non devono difendere un’immagine di sé.
🌌 3. Una logica spirituale rovesciata
Questa frase di Gesù è un rovesciamento radicale della gerarchia dei valori:
Non sono i colti a vedere Dio, ma i puri.
Non i dominatori, ma i miti.
Non i vincenti, ma i perdenti.
Non chi capisce tutto, ma chi accoglie tutto.
È una sfida anche per noi oggi, in un tempo in cui:
la razionalità è spesso idolatrata,
la complessità è usata come scudo,
la fragilità è vista come debolezza.
4. Cosa dice questa frase a chi pensa troppo?
A chi, come te, si interroga profondamente, legge Cioran, affronta il dubbio, questa frase può suonare non come un rimprovero, ma come un invito a non assolutizzare la mente.
Non ti chiede di smettere di pensare.
Ti chiede solo, forse, di non aspettarti la salvezza dalla mente.
In fondo, potremmo leggerla così:
“Quando la tua intelligenza arriva al limite, quando non ti resta che arrenderti al fatto che il senso non lo puoi costruire da solo… lì può succedere qualcosa. Lì, puoi diventare piccolo.”
E da lì, ricominciare. Non con risposte, ma con una presenza che ti visita, anche nel vuoto.
In conclusione:
Questa frase è un’eco del Qoelet e anche una risposta a Cioran:
non sei tu che trovi il senso. Il senso ti può visitare.
Ma non visita chi vuole dominarlo. Visita chi, nella notte, si fa piccolo.
Se vuoi, posso provare a scrivere un dialogo tra un “sapiente” (un uomo alla Cioran) e un “piccolo” evangelico. Sarebbe un incontro interessante. Vuoi che lo proviamo?
Un breve dialogo teatrale interiore, quasi fuori dal tempo, tra due personaggi simbolici:
Il Sapiente, una figura alla Cioran, disillusa, lucida, condannata alla consapevolezza.
Il Piccolo, una figura evangelica, povera di parole, ma ricca di accoglienza. Non ingenuo, ma semplice.
Lo scenario è essenziale: una panchina, forse all’alba. O forse dopo la fine di tutto.
“Il Sapiente e il Piccolo”
SAPIENTE
(seduto, sguardo perso)
Ho letto tutto.
Sviscerato il dolore, il tempo, la morte.
So che non c’è scopo.
So che tutto finisce.
So che ogni cosa bella è una condanna a svanire.
PICCOLO
(siede accanto a lui, in silenzio)
SAPIENTE
Sai cosa c’è dopo la vita?
Niente. Come prima.
Un grande buio che non guarda nessuno.
Eppure tutti fingono. Si aggrappano.
A Dio, all’anima, al paradiso. Favole.
PICCOLO
Tu soffri?
SAPIENTE
(ridacchia amaramente)
La sofferenza è l’unica verità che conosco.
PICCOLO
Allora non sei lontano.
SAPIENTE
Da cosa?
PICCOLO
Da Dio.
SAPIENTE
(ridacchia più forte)
Dio! Io l’ho cercato. Non l’ho trovato.
Ho cercato nel silenzio, nel dolore, nella logica.
Non c’era.
Solo il rumore del mio stesso pensiero.
PICCOLO
Forse cercavi un’idea.
Io non l’ho mai cercato. Ma Lui… a volte arriva.
SAPIENTE
E perché dovrebbe venire da te? Che non leggi, non pensi, non analizzi?
PICCOLO
Perché non mi nascondo dietro niente.
Lui ama le mani vuote. I cuori rotti. I piccoli.
SAPIENTE
(silenzio lungo)
Ma tu… non temi il nulla?
PICCOLO
Lo conosco. Ma non lo temo più.
Perché proprio lì, un giorno, qualcosa si è acceso.
Non l’ho capito. Non l’ho spiegato.
Ma mi ha scaldato.
E da allora non sono più solo.
SAPIENTE
Io non voglio consolazioni.
PICCOLO
Neanch’io. Solo presenza.
Tu sei ancora nel deserto.
Va bene così. Ma non restare chiuso.
Il deserto è il posto dove Dio cammina piano.
(Silenzio. Il sole sorge. Il sapiente non dice nulla, ma per la prima volta da tempo… ascolta.)