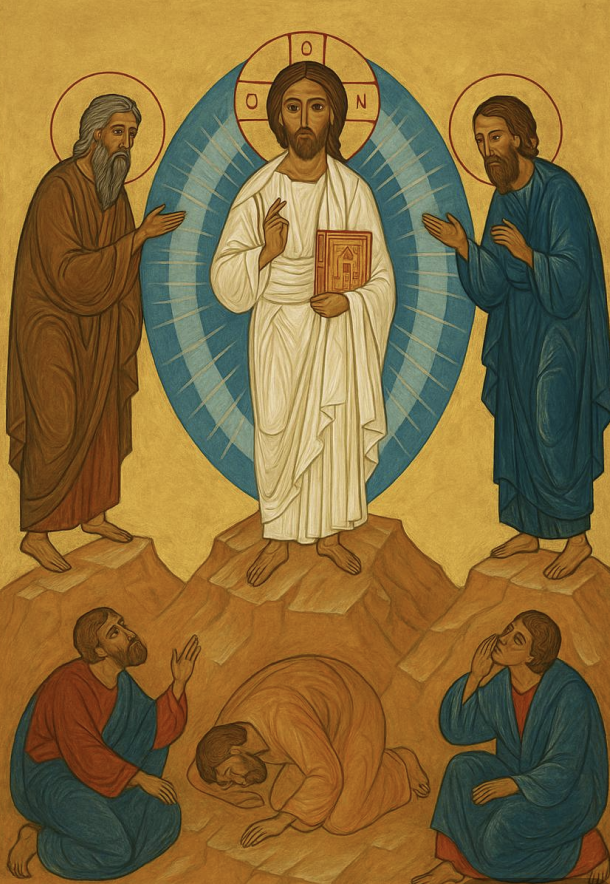Dopo il Concilio di Calcedonia (451 d.C.), la Chiesa cristiana si divise su come intendere la natura di Cristo (cioè il rapporto tra la sua divinità e la sua umanità).
Il concilio affermò la dottrina “di due nature in una sola persona” — cioè:
Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, con due nature (divina e umana) distinte ma unite nella stessa persona.
Le Chiese che non accettarono Calcedonia (come la Chiesa Copta Ortodossa d’Egitto) furono etichettate come “monofisite” (“una sola natura”), ma questo termine è un po’
La teologia copta non si considera monofisita nel senso estremo (cioè che la natura umana di Cristo sarebbe “assorbita” da quella divina).
I copti preferiscono definirsi miafisiti (dal greco mia physis tou Theou Logou sesarkōmenē = “una sola natura del Verbo di Dio incarnato”), secondo l’insegnamento di San Cirillo d’Alessandria.
In sintesi:
Gesù Cristo ha una sola natura unita, frutto dell’unione perfetta e inseparabile tra la sua divinità e la sua umanità.
Non si tratta di confusione o mescolanza, ma di unità senza separazione.
Quindi: divino e umano coesistono pienamente, ma non come due “nature separate”.
Differenze rispetto al pensiero “calcedoniano”
Calcedoniani (Cattolici, Ortodossi Bizantini): due nature distinte ma unite in una persona.
Copti (miafisiti): una sola natura “composita” in cui divinità e umanità sono inseparabili.
La differenza è più di linguaggio e terminologia che di fede reale — tanto che negli ultimi decenni ci sono stati accordi teologici tra la Chiesa Copta e la Chiesa Cattolica che riconoscono che, sostanzialmente, la fede in Cristo è la stessa
Nelle chiese copte c’è una visione teologica particolare di Gesù, che mette molto l’accento sull’unità della sua persona divina-umana.
Non si tratta però di “monofisismo estremo”, ma di una sfumatura teologica ereditata dalla tradizione alessandrina, che vede in Cristo un’unità profonda e indivisibile.
LITURGIA E ICONOGRAFIA COPTA
1. Nella liturgia copta
La spiritualità copta è profondamente cristocentrica: tutto ruota intorno all’unione tra Dio e l’uomo in Cristo.
Unione divina-umana nei testi liturgici
Nelle preghiere eucaristiche, i testi sottolineano continuamente che:
“Il Verbo di Dio si è fatto uomo senza cambiamento, e la sua divinità non si è separata dalla sua umanità neppure per un istante.”
Questa frase è un condensato della teologia miafisita:
“senza cambiamento” → l’umanità non distrugge la divinità;
“non separata neppure per un istante” → non ci sono due nature “divise”, ma un’unica realtà unita.
Durante la Divina Liturgia di San Basilio (la più usata nella Chiesa Copta), il sacerdote proclama:
“Tu hai unito le cose che erano separate, e hai fatto di esse una cosa sola: l’uomo e Dio.”
Questa formula liturgica è teologicamente potentissima e riassume il cuore della visione copta: Cristo è il punto d’incontro tra cielo e terra.
2. Nell’iconografia copta
Le icone copte hanno uno stile molto riconoscibile e “teologico”: servono a rivelare il mistero, non a rappresentare in modo realistico.
Il volto di Cristo
Spesso simmetrico, per indicare la piena unità di divinità e umanità.
Gli occhi sono grandi, segno dello Spirito e della sapienza divina.
La posizione frontale comunica presenza eterna, fuori dal tempo.
Non è raro trovare, in alcune icone più antiche, una leggera differenza tra le due metà del volto (una più “umana”, l’altra più “divina”) — ma sempre fuse in un’unità, non separate.
Questa simbologia deriva proprio dal concetto miafisita: una sola natura incarnata del Verbo.
3. Implicazioni spirituali
Per i copti, l’incarnazione non è solo un fatto passato, ma una realtà continua:
Dio e l’uomo sono ormai inseparabili in Cristo, e quindi la salvezza è partecipazione reale alla natura divina (tema che riecheggia anche nella spiritualità orientale in generale).
Questo spiega anche perché la devozione ai martiri e ai santi è così forte: sono visti come icone viventi di questa unione trasformante tra umano e divino.